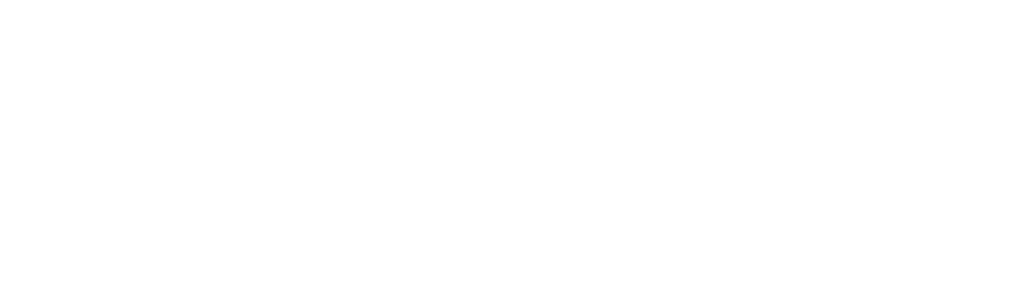La storia, non sa mica tutte le storie: gli storici più onesti rabbrividiscono innanzi all’immensità del mistero che da ogni parte gli sfugge; e considerano col cuore stretto d’angoscia l’esiguo granello di conoscenza che è loro concesso contemplare. Le storie, si sa dove nascono, e dove si possono incontrare e diffondere: nelle osterie e per le strade – strade di terra e, s’intende, di mare – ove la gente vive (o viveva, giacché oggi si è troppo occupati a lavorare per avere anche il tempo di esistere e guardarsi attorno o, Dio non voglia, pensare e chiacchierare) la propria vita, verità menzogna e sortilegio. Noi, che all’osteria ci stiamo di casa e quando non siamo lì dentro è solo perché vaghiamo il vasto mondo come cani filosofi annusando ogni canto e paracarro, storie ne incontriamo fittamente; ne siamo invasi addirittura; e – per liberarcene o per illuminarne le genti o mari per puro sfizio vedete un po’ voi – ogni occasione è buona per raccontarne qualcuna. Questa, ad esempio: che, sono pronto a scommetterci un branzino ai ferri, è universalmente ignorata: sebbene riguardi il sommo Leonardo da Vinci: uno che, lui pure, ne ha fatte tante e così curiose sa suscitare per secoli l’attenzione di dotti e indotti. Dicano e disquisicano della sua pittura e d’altre passioni sue gl’intendeti e i biografi. Non vogliamo occuparci – oggi, e domani chissà – del suo amore, più o meno segreto, per la musica, il canto e la cucina. Nella Firenze dei tempi suoi s’incontravano, e fortunato chi c’era, geni per strada come se piovesse. E siccome gli artisti, come anche quelli che non hanno la fortuna o la sventura d’esserlo, si trovano sovente in vena di monellerie e zingarate, non di rado accadeva che Leonardo, Sandrino Botticelli e il più torvo e casinista di tutti, Michelangelo, stufi di tele e pennelli, impervessassero per le borgate di Firenze o in qualche campagna a romper timpani in sfrenate canzonacce o in qualche scherzo toscano.
Un giorno, così tanto per amore di novità, venne a qualcuno l’idea di andare a pigliarsi un bicchiere di vino in Liguria. Terra del belino, si sa, la Liguria, specialmente a raggiungerla, allore, vuoi per terra o per mare; ma ai tre ormai la voglia era venuta, e vile sarebbe stato non spegnerla. Terra di rompiballe, anche; insomma, terra da visitare assolutamente. La curiosità s’era acuita da quando quello scassacazzi d’un Zeneise s’era messo a girare per tutte le corti d’Europa con la scusa che doveva scoprire la Colombia e poi, scemo o scalognato che era, andò a scoprire l’America, e fece un piacere a mucchio d’altri – metti il fiorentino Vespucci per primo e poi i vari re di Spagna, Francia, Portogallo, Inghilterra, giù giù sino alla polacca Levinski – mentre lui finì in galera, e ben gli stette. Ma a parte questo il Cumbao aveva sparso in giro, oltre al fantasmo degli indiani, un profumo di pesto e d’arzilio da portar via ed affascinare ogni naso che si rispetti: e aveva messo il diavolo in corpo ai tre pittori in particolare: che avevano copiose polluzioni gastronomiche notturne e diurne sognando trenette al pesto e cima, taglierini allo scoglio e focacce. Leonardo si svegliava di notte urlando e sbavando: ricci,atelle, branzini, ostriche, aragoste, mari e monti di Liguria erano diventati la sua ossessione.
Insomma, s’ha da decidersi, E ci si decise. S’accordarono, lui e Sandrino Botticelli, di raccontare una mussa a mastro Verrocchio, presso cui erano a bottega e con la scusa di dipingere dal vero aragoste, muscoli, cicale di mare, saraghi e ippocampi, così tanto per innovare un po’ l’arte e inventare, chi sa mai, il Rinascimento o la pittura allegorica o grottesca e insomma quel che sarebbe venuto, magari l’astrattismo e la body art, chiedergli il permesso di recarsi nella selvatica Liguria.
Verrocchio – vecchio sì, rincoglionito no – da tempo anche lui aveva sentito mirabilia della cucina ligustica sicché gli eran sorte le medesime voglie dei giovani anche se, come accade, aveva meno forze e minor disposizione all’avventura per andarle a spegnere: fu ben lieto, dunque, di stare al gioco: finse di bersi la fola e, dopo essersi fatto adeguatamente pregare, acconsentì: solo impegnò Leonardo a riportargli da quei luoghi un barilotto di acciughe di Sestri Levante, in quei tempi già rinomate in Firenze per il profumo d’arziglio e la delicatezza che le contraddistingueva da quelle, grasse e fangose, del Sud. Ma costavano così care che nessuno riusciva a fare il conto; e solo i Medici, e raramente anche loro, potevano permettersele. Sicché restavano nei sogni, e solo nei sogni, dei comuni mortali.
“Anzi, vi presto cavallo e carretto” – aggiunse il vecchio, con un sorriso umido che gli scappava da sotto la barba, “così mi fate la spesa grossa. E, beh, giacché siete lì a Sestri usatemi pure il favore di portarmi una cesta di fichi secchi di San Bernardo, che solo lì, dicono, sono sì dolci; e un vaso di capperi della Mandrella sottaceto, che alla bisogna li cacci nella salsa tonnata; e ‘un vi scordate il pesto, di ‘apisce; e pigliate su una dozzina di stelle marine secche – e attenti a non spezzarne le punte, bischeri, che ne voglio spargere a garbo di signore che so io”. Leo, Sandrino e Michè non vedevan l’ora che il vecchio tacesse, e dondolavano sui tacchi impazienti di andare; ma quello riprese: “E coglioni che siate ‘un potete sbaglià manco volendo: pigliata che abbiate a Pisa la vecchia Aurelia, tirate sempre innanzi al naso. E però miha tutto è liscio; sihhé ‘on vi salti in testa di passare per il Bracco soli: e o v’intruppate in venticinque o trenta, e pure bene armati, o non movete piede: perchjé, o coglioni, lassù s’accampano i briganti, tagliaborse tagliagola e taglia qual che ‘apita tagliare.
Dunque se salvate borsa e culo – e v’avverto: se non salvate la borsa non tornate – sarete tosto in vista d’una valle ampietta e ferace molto d’una graziosa penisola e due golfi: e quella è la Segesta de’ Tigulli, o Siestri che si dica. Arrivati quivi, prima di briacarvi, andrete all’Isola al palazzo de’ Fieschi humilmente et honestamente affermando voi quali siete miei scolari et adepti, per la cui ratione sufficiente essi vi saranno, per quanto si possa come genovesi, larghi.
Et a notte badate non bighellonare a spiagge perché sovente quivi giungono senza preavviso ‘un si sa da dove turbe di saraceni assatanati che, piglia piglia, ciò che agguantano strigliano e sparigliano e senza punta filosofia vi allentano uomini, donne e cani”.
Per null’affatto turbato dal pericolo, perlomeno non da questo, Leonardo – di cui il lettore apprezzerà senza fallo l’ardire – tutto eccitato brancicò Sandrino: “E dunque, si va o s’indugia?”.
“Si va, si va” dissero in coro Sandro e Miché.
Giunsero, i tre, dopo una decina di giorni di cammino e d’ozi: pessime le strade, infatti, e pessimissimi e tremendissimi i banditi “De Ciuffardinis” stanziali sul Bracco, a rallentare la marcia dei viaggiatori in giorni interminabili; ma a vero dire il viaggio non acquistò velocità anche in pro di alcuni giorni di beata dimenticanza trascorsi nella splendida Luni a ingozzarsi di testaroli e a imbeversi come spugne entusiastiche del Vermentino dei Conti Malaspina nonché di quello dei Conti Picedi Benettini.
Il primo ad avvistare Segesta fu, dal Poggio di Makallè, Michelagnolo che per l’entusiasmo di giungere in frette si precipitò giù in una scorciatoia ove ruzzolò fratturandosi il naso che, greco che era sempre stato, gli divenne sghembo pel resto della vita sua e degli altri.
Bene o male, e col Miché discretamente sconcio, giunsero i tre ad una delle dimore estive dei Fieschi, mentre il padrone di casa, papa Innocenzo V, stava molcendo le faticate membra nella Baia del Silenzio, circondato da un discreto esercito di fidi inquisitori che, fra un arrosto di strega e uno d’eretico, si concedevano un friccico di ricreazione, mentre servi indigeni gli portavano ricci aperti e freschi calici vini del Missanto.
Più per stanchezza che per onorare i discepoli del “caro Verrocchio” (e dicendo “caro” il Fiesco pensava, col cuore lacrimante, a quanto costava alle Sacre Casse il pittore), emerse dall’acque iodate alla riva ove una giovine streghetta, opportunamente redenta e vittoriosamente strappata alle grinfie del Maligno, si prese buona cura della parte visibile e mortale del buon Vicario di Dio in terra.
Leonardo ammirava la baia, la bella strega redenta, i giovani servitori dalla voce roboante, i piedi gottosi del papa e i ricci che non aveva mai visto; e tanto per dire qualcosa propose al Papa e padrone di casa di affrescargli a nuovo il Palazzo praticamente agratis o a prezzi d’affezione, insomma in cambio di vitto, alloggio e quel minimo di merce da riportare a mastro Verrocchio.
“E perché no?” – calcolò fra sé rapido il Papone: “dopotutto può essere un buon investimento: poni che un giorno ‘sti pellegrini diventino famosi, e che mi costa?”. Per giunta, una bella camera piacevolmente e maliziosamente affrescata è sempre meglio di una cella imbiancata: sulle donne fa sempre colpo, va’ a sapere perché; e lui aveva giustappunto udito che a Bargone vivevano e operavano certe streghine indiavolate per esorcizzare e riportare in seno a Santa Chiesa le quali egli stava meditando di sperimentare e adottare un nuovo sistema di sua invenzione.
“Naturalemnte – Innocenzo V da buon genovese volle precisare i termini dell’accordo con i pittori – di palanche non se ne parla. Del resto, vedrete che qui denaro non ne serve; qui – sorrise – vige il baratto: tu mi dai una cosa che hai, io ti do qualcosa in cambio. Se ne ho voglia”.
Avete mai provato, voi, a discutere con un papa? E con un papa genovese? E con un papa genovese del Cinquecento?
I tre si misero all’opera. A Leonardo piacque disegnare i particolari dei tentacoli del polpo e le teste dei gamberoni imperiali; prese come modelli giovini pescatori di Segesta dai tratti saraceni, con i quali si soffermò fino a notte tarda e a lume di candela, a disegnare particolari anatomici che a Firenze non aveva mai visto.
Sandro si dedicò alle aragoste: nel senso che un po’ le dipingeva, un po’ le ingollava, innaffiate di bianco dell’Elba. Miché si misea scolpire: sembra certo che fu lui a rifinire il profilo dell’Isola; di Punta Manara; lui a ritagliare dal monte la massa d’ardesia dello Scoglio Campana.
A farla breve, i tre s’innamorarono del luogo – e di qualche altra bellezza – e decisero di fermarcisi, chissà, forse per sempre.
Mettendo assieme l’amore per il canto, la cucina, il vino e in genere per tutte le gozzoviglie dei sensi, decisero – e non ci fu bisogno di alcuna discussione – di aprire una bella osteria.
Chiesero al papa, come favore speciale e segno straordinario di benevolenza, di poter usare le stalle del palazzo per ricavarci, dopo opportuna ripulitura e restauri approrpiati, una primaria osteria, la migliore che mai si fosse vista e praticata in quelle terre e in quei climi.
Leonardo per di più rassicurò Innocenzo V: “Non dubiti, santità, se intercetto una giovinella con aria di strega, gliela mando subito sù nella Sua stanza onde Vostra Santità possa applicarle il metodo sperimentale di destregazione: meglio bloccarle da piccole…” Innocenzo V – savatt sandir – acconsentì; senza peraltro privarsi del piacere di porre una condizione: “figgeu – disse – scemi non mi sembrate. E allora, risolvetemi un po’ questo problema: come vedete – e che però non si sappia in giro – io sono senza denti e questo mi riduce a biascicare poltiglie schifose e oltraggiose. Voglio – dico voglio – che la prima ricetta del ristorante che vi regalo (nel senso che ve lo offro in gestione, sia chiaro e sia anche chiaro che tutti i profitti vengono a me) sia un piatto nutriente, guistoso, e che non dia lavoro alle gengive. Se semmu accapii?”
“Capito, Santità”, disse Leonardo, i cui circuiti cerebrali erano già intasati di idee.
Michelangelo si mise tosto all’opera per trasformare le stalle abominevoli in ristorante: progettò fornelli a legna e ronfò con grosse pentole per friggere l’olio (gliele donarono, usate, gli inquisitori, che aseguito dell’adozione del nuovo sistema di conversione delle streghe e delle eretiche inventato da Innocenzo se ne ritrovaroo una considerevole quantità in eccesso).
Leonardo era la prima volta che faceva un ristorante, ma subito fu all’avanguardia nel progettare utensili e macchine da cucina. Inventò – e realizzò – un lava-patate meccanico a manovella, un lavapiatti a pedale che riciclava l’acqua calda della pasta, il ruotino per fare i ravioli e un piccolo frullatore a manovella per montare le salse nonché un estrattore automatico per i fumi della cucina. Quanto alla ricetta richiesta dal papa, dovette pensarci almeno sette secondi prima di trovare la soluzione. Sapeva che il polpo (il polpo era l’animale che più gli era rimasto impresso da quando era venuto a Segesta de’ Tigulli, il più sensuale e sontuoso: magnifico: mille volte meglio delle aragoste che piacevano a Sandrino e che tuttavia gli diedero l’idea del carro da guerra e del sottomarino d’attacco) era ricco di proteine, quindi sarebbe andato bene come energetico per il papa, però c’era un problema: anche cuocendolo ore ed ore rimaneva duro e gommoso e per giunta perdeva le sue proteine essenziali.
Dopo sette secondi, dunque, di estenuante meditazione, quando già stava per scoraggiarsi e stizzirsi con se stesso, disse: “toh”, e cominciò a buttar giù gli schizzi per eseguire un frullatore composto da 4 cucchiai taglienti azionato a manovella e finalizzato allo spappolamento programmato del polpo uso crema.

Assieme ad un fabbro di nome Memè, nativo della borgata di Cà di Ferae, situata all’estrema periferia a Nord di Segesta, Leonardo costruì il primo frullatore a manovella: prerequisito tecnologico indispensabile alla realizzazione della ricetta; quindi scottò il polpo per non più di 10 minuti, in modo che mantenesse integre le proteine, lo spellò e lo frullò ponendo in un recipiente di terracotta un bicchiere di fragrante olio d’oliva della famiglia Bo di Rio Ravino e una manciata di capperi della Mandrella che gli fornì la famiglia dei Borani.
Raggiunta la consistenza di una crema lo pigiò in una arbanella di terracotta e gli mise due dita d’olio sopra per conservarlo meglio. Innocenzo V lo assaggiò, il polpo gli si sciolse in bocca nel sollucchero delle sue papille gustative, e successivamente ne provò il vigore con ampio successo nei giorni successivi.
Il nome glielo trovò il Botticelli, che della compagnia era il più colto e aveva letto Dante e sapeva il francioso: patè di polpo, propose, e disse che bisognava fare così per dargli un po’ d’importanza e che questo costituiva anche, in qualche modo, una significativa anche se modesta, operazione di marketing. Lo lasciarono dire, ché non aveva mai fatto male a nessuno;e fecero come voleva lui, perché sapevano che un nome vale l’altro e quello che conta intanto è l’opinione del papa.
Il neonato patè (“patè patè” – bulava impietoso Michelangelo – “polpopatè e polpette”) lo servivano su crostoni abbrustoliti di pane nel levato (grosse focacce che portavano le contadine giù dai monti).
Piatto tipico di Segesta era allora il “Ciupiin de Scorfanis” che i pescatori mangiavano succhiando e sputando perché era pieno di lische; Leonardo trovò il modo di costruire un cestino a maglia fine, dove dentro ruotava e premeva verso il fondo un’elica a 6 pale che girando separava le lische dal succolento brodino; Michelangelo ingentilì la zuppa aggiungendo una salsa all’aglio e caldi crostini imburrati. Nacque così a Segesta la prima Bouillabasse che Leonardo vendette in seguito ad un ristoratore di passaggio della vicina Provenza, dove il piatto ebbe grande successo e tutt’ora è un piatto alla moda.
L’insegna del nuovo locale fu ricavata da un vecchio timone di leudo su cui Sandro ad onore e merito del piatto del suo inventore: Ristorante Polpo Da Vinci.
Il menù si intestardì a volerlo scrivere Leonardo: a rovescio, com’era suo costume: sicché per leggerlo bisognava guardarlo in uno specchietto; ai clienti comunque non dispiacque questa originalità. E miché sogghignava: “un’operazione di marchettin anche questa”.
Il ristorante ebbe successo e anche nobiluomini e nobildonne venivano all’osteria ad assaggiare questa nouvelle cousine cinquecentesca. Sandro, Leonardo e Michè arrotondavano gl’incassi (del papa) disegnando sulla carta matta ritratti a carbone dei clienti: e si capisce che tentavano di accordarsi coi signori – i vari Spinola, Doria, Pallavicini, Grimaldi – sulle parcelle per un bel quadro ad olio; e a quelli l’odea in sé non dispiaceva: quello che gli dispiaceva era tirar fuori le palanche: sicché contrattavano proponendo compensi in vitto e alloggio (dei quali tre, già disponendone ad abundantiam non sentivano alcun bisogno) oppure (purtroppo solo le vecchie signore) in natura: sicché non si concluse mai nulla: ed è per questo che i grandi casati genovesi non vantano tele ed affreschi di questi tre grandi.
I quali, visto l’andazzo, si contentarono di fare i ristoratori.
Non di rado Sandrino Botticelli cantava canzoni picaresche accompagnato dal Laud di Leonardo, mentre Michelangelo scoteva la testa e bofonchiava.
Leonardo non volle mai fare nemmeno un piatto di Firenze: i ricci, i polpi, le loturie, gli anemoni di mare, le fresche alghe marine, le patelle ed altre curiosità gastronomiche che il suo palato prima non conosceva stuzzicarono la sua fantastica inventiva e con le sue conoscenze culinarie (absit iniuria verbis) e insomma con la sua variegata cultura di gourmet inventò piatti che passarono alla storia: gli stecchi, che allora erano solo di carne, diventaroo fragranti manicaretti al profumo di arzilio, ripieni di ostriche, anemoni e frutti di mare.
Inventò il totano ripieno seguendo il criterio e la logica dell’arte della cima genovese.
Le nobildonne venivano a mangiare i corzetti con i ricci di mare, le ostriche ripiene con spinaci e bechamelle, le aragoste fiammeggianti al Calvados (sottratto alla ben fornita cantina del papa).
Leonardo seviva tutto in piatti e sperlonghe con forme in rilievo raffiguranti il prezioso manicaretto realizzate, s’intende, da lui stesso (sotto i pavimento del Polpo Mario forse ce ne sono ancora).
La Liguria in quei tempi era misera di dolci, ma Leonardo riuscì ad inventare un dolce straordinario con un prodotto che si dava ai maiali tanto ce n’era in abbondanza: le castagne con le quali elaborò per la prima volta al mondo il soufflè caldo di castagne.
Le clienti impazzite dalla bontà e dalla stravaganza dei un dolce che si alzava da solo nel forno, lo propinavano ai mariti nella speranza che, la notte, li ispirasse ad altri innalzamenti.
Le streghe della cameretta sul mare, confessavano a viva voce qualunque antecedente rapporto con il diavolo, pur di averne una sola porzione; Papa Innocenzo V lo inserì nel menù di corte per un anno di fila.
Tutto – o, beh, quasi tutto – andava a gonfie vele. Le macchine, occorre dirlo, davano qualche problema. In particolare l’impianto di estrazione dei fumi della cucina (consistente in una grossa elica collegata con cinghie e pulegge ad un palo verticale esterno tirato alla soma di 4 cavalli da tiro) si rivelò lontano dalla sperata perfezione: accadeva, infatti, che l’odore degli animali ch saliva alle papali stanze finisse deplorevolmente per sommarsi al tanfo dello stoccafisso proveniente dalla cucina: Il papa cominciò a mugugnare: Poi s’incazzò proprio. Leonardo aveva oramai finito di dipingere in largo e specilamente in lungo i particolari dei giovani pescatori Segestrini; Sandro si rivelava un concorrente indesiderato nell’accudire ai bisogni del corpo e dell’anima di contadine e nobildonne. L’avventura era finita. I tre che, come acutamente aveva compreso Sua Santità, non erano mica scemi, videro che il vento cambiava. Ebbero la faccia tosta di impetrare umilmente alla generosità di Sua Santità un dono per mastro Verrocchio – che da un pezzo aspettava a Fiorenza; l’ottennero e partirono.
Il ristorante passò alla famiglia dei vinacceri Bo, rinomati naviganti e commercianti di vino dell’Elba proprietari di leudi e feluche.
Nel 1980 il Ristorante Polpo Da Vinci passò all’attuale proprietario Rudy, che lo chiamò Polpo Mario per via di una storia che forse non a tutti è ignota.
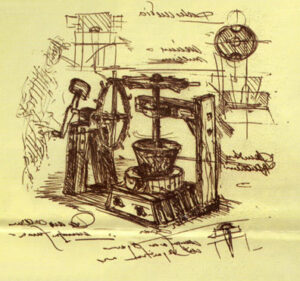
Il patè di polpo si fa ancora alla maniera di Leonardo Da Vinci e trionfa tra le prime righe del menù. Solo, il frullatore è considerevolmente migliorato da allora.
Leonardo passò al servizio dei Medici, forse grazie al patè di polpo di cui Lorenzo rimase entusiasta. Leonardo lo propose come energetico per la milizia di Lorenzo dei Medici, peccato che l’approvvigionamento dei polpi in Firenze fosse difficile in quei tempi.
Leonardo, nonostante fosse occupato a disegnare fortificazioni, a dipingere affreschi e tele per i potenti del tempo, continuò sempre a dedicare parecchio del suo tempo ai fornelli. Sicché il titolo accademico che più gli piacque fu quello di maestro pasticcere che gli diede Ludovico Sforza chiamato Il Moro. E pensare che se il progetto di estrazione d’aria del ristorante avesse funzionato Leonardo sarebbe diventato solo un grande ristoratore e a noi posteri sarebbero mancati La Gioconda e il Cenacolo. E se Leonardo in cucina da straordinario inventore, poeta e artista qual era ci avesse lasciato piatti pari o superiori ai suoi quadri?
Non lo sapremo mai, dobbiamo accontentarci del patè di polpo.