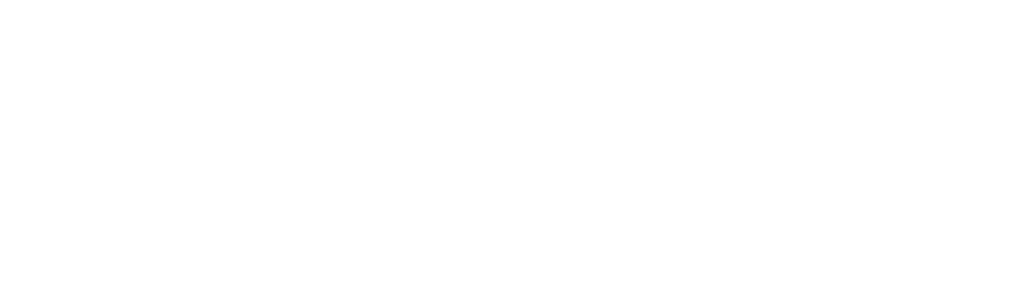Ermetismo: fu l’accusa che nel 1936, se non ricordo male, Francesco Flora gettò sulla nuova poesia che si faceva in Italia.
Pronunciamo i nomi di Campana, Ungaretti, Montale, e il quadro è già sufficientemente alluso. Aggiungiamo quelli che vennero più tardi: Quasimodo, Luzi, Gatto, e mentre il panorama si completa, vediamo – tutti vedono, poiché anche coloro che meno sono dedicati alla quotidiana frequentazione della poesia non ignorano la statura di tali personaggi – come dal gruppo degli uomini, che furono riuniti sotto l’etichetta inizialmente sprezzante dell’ermetismo, si siano espresse voci fra le più pure del novecento; fra le più alte e convincenti che mai si siano levate nella letteratura, non solo del nostro tempo e non solo del nostro paese.
I riconoscimenti internazionali non sono poi mancati: il più autorevole e ambito di tutti, il Nobel, fu assegnato a Quasimodo e Montale; mentre a Luzi, felicemente ancora scrivente e ogni anno, a quanto si dice, nella rosa dei candidati, lo fanno sospirare.
Non è il Nobel, naturalmente, come nessun altro premio per quanto serio ed autorevole, che potrà dare la misura di un artista; eppure la sua assegnazione qualcosa dice, indubbiamente.
Dice, se non altro, quant’acqua passò sotto i ponti nei due decenni che separarono la frettolosa condanna pronunciata dal Flora e il Nobel a Quasimodo (1959). E dice anche quant’è difficile, per un lettore onesto, anche per il più acuto e intelligente dei lettori – e Francesco Flora fu critico fra i maggiori, serio e appassionato – districarsi dal groviglio dei pregiudizi, ovvero da una tradizione vissuta come totalità, o poco meno.
Lo stesso Croce, che di Flora fu maestro così come di un numero incalcolabile di giovani per un numero incalcolabile di decenni, non riuscì mai, nonostante tutto – nonostante la distanza che felicemente lo divideva dal pascolismo e dal dannunzianesimo e nonostante la sua indubbia onestà e sensibilità – ad entrare in contatto con la poesia moderna; a partire diciamo da Mallarmè, che degli ermetici fu nume tutelare e orizzonte; ma si potrebbe forse dire anche da Leopardi.
E per questa sua chiusura alle ragioni d’una nuova spiritualità, per la sua irrimediabile e radicale estraneità al nuovo modo d’intendere la poesia, finì per mettersi di traverso, a dispetto dei suoi meriti, che furono moltissimi e importantissimi, alle nuove linee di sviluppo della cultura moderna; e bisognò scavalcarlo. Ma scavalcare Croce non era affare da poco; non poteva bastare il fatto, l’evento, per quanto roccioso e colossale, della nuova poesia.
Occorreva una consapevolezza critica e morale che affiancasse la nuova poesia e chiarisse, in collaborazione diretta al suo farsi, le ragioni del suo esistere e insomma portasse nella prosa, nella filosofia, nell’etica lo stesso fervore di lavoro, lo stesso profondissimo bisogno di catarsi e di integrale rinnovamento che aveva rivoluzionato le forme della poesia novecentesca. Cade qui, inevitabilmente, il nome di Carlo Bo, che nell’opera sua, nel breve volgere di quattro o cinque anni cruciali, fra il 1937 e il tempo della guerra, seppe farsi fuoco, crogiuolo, coscienza, anima e bandiera dell’ermetismo, con sofferta passione e intelligenza. Poi furono le cose a imporre un severo bilancio, e nel dopoguerra l’esperienza dell’ermetismo lasciava il passo a nuove esigenze e veniva il tempo del neorealismo; ma non finiva altrettanto presto l’influsso di una poetica che così a fondo aveva scavato nell’uomo; e di quella stagione, nella quale la cultura italiana seppe stabilire vette valide per tutti, restano i risultati della poesia che può essere di tanto in tanto fraintesa, ma non cede alle mode. E resta. Carlo Bo è di Sestri Levante; e seppur dovette, com’era inevitabile, staccarsene per studiare e lavorare e gettarsi a corpo morto nei luoghi privilegiato ove fosse possibile collaborare al farsi della cultura e della poesia, pure non perse mai i contatti con il suo paese; e sebbene la sua statura trascenda i limiti di nazione e di classe, portò con sé a Firenze e ovunque si sia poi spostato, la sua ligusticità, anzi la sua sestrinità; e nei bilanci che periodicamente si fanno sull’Ermetismo, bisognerebbe, un giorno, decidersi a contare le pietre e i sassi di questa terra o di altre simili a questa, egualmente scabre e marginali.
Ma di questa sopra tutte. E se il contributo della Liguria alla poesia del nostro secolo è ampiamente noto e variamente commentato, tanto che si è potuto parlare di una linea o addirittura di una scuola linguistica, mi pare non si siano si sono approfondite abbastanza le ragioni di questo fatto. E non sarò io, in questa sede poi, a risolvere il problema. Qui mi piace sollevare un po’ di polvere, inseguire una suggestione.
Sestri, minimo borgo alla periferia dell’universo, non poté certo svolgere, né in quegli anni né poi, la funzione propulsiva di un grande centro culturale; eppure eppure, eppure… Bo portò con sé a Firenze e altrove le proprie radici, che ancora pescavano nell’acqua del Ravino; il peso della sua sestrinità nella sua opera è ancora da studiare e tuttavia, ne sono certo, assai alto; e quando la meravigliosa zavorra della nostalgia, la fisica necessità di tornare a respirare l’aria del borgo, ad accarezzare l’indimenticata scabrosità degli scogli neri lo riconducevano qui, si portava dietro pezzi di Firenze, insomma brandelli di mondo e di eternità, e amici importanti e illustri; e Sestri diventava, magari soltanto per un attimo, senza che nessuno lo sospettasse ma come per elezione, uno di quei luoghi privilegiati ove le cose accadono, ove la poesia accade; quel centro di cultura che non poteva essere e non era.
Eppure, eppure, eppure…
C’è in questo paese, nella sua luce, nelle sue pietre, nell’armonia delle sue curve e del suo disegno – parlo, s’intende, della natura e del paese antico, certo non di quello che la stupidità ha edificato nel secondo dopoguerra e continua a ingrandire, insidiando la possibilità stessa della meraviglia – c’è in questo paese un segreto simile a quello della poesia, che la evoca o magari chissà, talvolta la sostituisce; c’è (penso alla magia per la quale, ad esempio, chi sfiora il cerchio gentile della Baia di Portobello si sente cadere fuori del tempo) qualcosa di più della bellezza, una sorta di assenza o di attesa che si ritrova tale e quale negli scritti di Bo; e in molti testi degli ermetici.
Qualcosa del genere, il povero Campana, che di tutti fu, forse, il temperamento più bruciante, e nativo di poeta e finì pazzo, riconobbe nello specchio del porto vecchio di Genova, nell’odore di piscio e di mare che stagnava agli angoli dei carruggi. Montale, si sa, inutile sprecar parole.
Quasimodo, dovette trovare qui robusti echi del suo mito: la Sicilia qui è più vicina che altrove; “Oboe sommerso” (1932), il libro d’esordio del suo ermetismo, nasce e matura in Liguria, nell’ambiente di Circoli, nel contatto con Sbarbaro, Grande, Barile, Montale.
Piccola, poverissima Liguria, come diventano sciocche e meschine e miopi le lamentele eterne sulla mancanza di cultura che l’affliggerebbe. Vi sono certo casi, e dolorosi, in cui queste accuse sono vere, e la mancanza di cultura sin troppo concretamente palpabile; ma sono in genere casi che i piagnoni preferiscono non vedere o sono incapaci di cogliere. E poi, abitava a Sestri in quel tempo, un piccolo uomo e poeta delicato e autentico, uno che aveva nel sangue l’avventura e la poesia, la partenza e il ritorno, uno che si trovò a vivere nel paradossale crocevia di artisti che fu Sestri in quegli anni; uno che conobbe il mondo, il vasto mondo, e senza alcun segno d’orgoglio eppure fermamente, con tutta semplicità ma anche con la coscienza che niente al mondo era possibile, se ne ritrasse, o meglio continuò per la propria strada, ai margini del mondo. Gioanin Descalzo ebbe una vita da personaggio romanzesco, tipo Martin Eden, come è stato osservato; girò il mondo e poi tornò a terra e senza alcuna discontinuità s’impiegò in un ufficio postale, fece l’operatore in un cinema, lavorò alla Tubifera, e poi in Comune. L’avventura l’aveva dentro, era la sua poesia. “Descalzo – scrive uno dei suoi maggiori studiosi – aveva modo di allargare i propri orizzonti nella stagione estiva, quando trascorrevano le vacanze a Sestri Levante numerosi intellettuali ed artisti; tra questi, oltre all’etruscologo Hans Muhlenstein – che gli propose, senza successo, di pubblicare presso un editore elvetico i suoi primi versi – Descalzo conobbe il romanziere olandese Artur Van Schendel che per primo avrebbe parlato di lui con favore nell’ambiente fiorentino di “Solaria”. Solito compiere viaggi culturali nei suoi giorni di ferie da operaio, nel settembre del 1931, Descalzo si recò a Firenze e incontrò Montale al Viesseux”. Tra i due poeti ristabilisce una corrente di cordialità e di reciproca intelligenza; ma resta qualcosa di freddo: la scintilla della simpatia umana non scocca; e cosi sarà ogni volta che si incontreranno.

Nell’aprile del 1936, Descalzo, spinto dall’illusione di rivedere Montale e avvicinarsi meglio al suo spirito, accetta l’invito di Lucia Dodocanachi e si reca ad Arenano per partecipare, il lunedì di Pasqua, ad un incontro conviviale tra scrittori e artisti.
Ma già durante il viaggio in treno, compiuto assieme a Montale e Carlo Bo, aveva cominciato a sentirsi a disagio; l’ambiente salottiero dell’incontro finisce di disgustarlo; e di Montale scrive piuttosto acidamente nel suo diario: “Montale m’ha deluso assai più della prima volta.
Non sente che il suo dolore al piede sinistro, alla gamba destra e non so più a quale altro punto del corpo. Tutto ciò che accade, l’intensità con cui si vive, non lo distrae dalle sue piccole sofferenze che ha bisogno di esternare ogni tanto con un lagno o con un sorriso agro a fior di labbra”.
Poi si rivedono a Firenze e Descalzo, vivamente, acutamente e anche impietosamente annota: “Montale, arido e infelice, m’ha accolto con amicizia, ma che imbarazzo ogni volta che lo ritrovo!
E’ certo uno dei più grandi poeti e soffre di chissà quali mali interiori, ma l’ammirazione al suo contatto decade per lasciare il posto a un sentimento che confina a volte con la pietà”. L’unico momento, forse, in cui i due parvero avvicinarsi a una comunicazione, e scaldarsi del reciproco calore umano, è dato da un pomeriggio trascorso assieme in una apprezzabilissima osteria di Sestri Levante.
A noi piace pensare, s’intende, che l’apprezzabilissima osteria fosse proprio il nostro Polpo Mario, e perché no; così come ci piace pensare che il dramma raffigurato nella poesia “Il polpo” immortalasse proprio l’efferato e celeberrimo episodio della cattura del mitico Mario da parte del fiero Cesare, re della Baia di Portobello.
E dintorni…
Vincenzo Gueglio